MATERIA PRIMA
Ascoltare il disagio di chi cura
Numero XXI - Dicembre 2021 - Anno XI
Intervista al Dott. Giorgio Rossi
Direttore S.C. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza - ASST Sette Laghi di Varese
di Simona Gazzotti, Costanza Ratti, Giorgio Cavallari
abstract a cura di Elisa Di Pierro
L’Intervista al Dott. Giorgio Rossi, direttore S.C. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, ASST Sette Laghi di Varese, si propone di offrire un’attenta considerazione ai soggetti in età evolutiva che, con l’epidemia COVID-19, hanno mostrato un rilevante incremento di varie forme di malessere come comportamenti autolesivi, a volte di esito mortale, e disturbi alimentari. L’incremento significativo della sofferenza psichica di molti minori e delle loro famiglie merita giusta preoccupazione e rispetto, e dovrebbe attivare interventi finalizzati alla prevenzione, sostegno, studio dei problemi e cura. Il Dott. Rossi inizia offrendo qualche dato sulla diminuzione degli accessi agli ambulatori - come conseguenza alla preoccupazione del contagio e al fatto che le mascherine hanno permesso una minor diffusione di virus respiratori e di altra natura - che però non ha riguardato la psichiatria e neuropsichiatria infantile dove gli accessi al pronto soccorso si sono mantenuti uguali rispetto a prima della pandemia, con un aumento progressivo nel corso del 2020 di autolesività e suicidarietà. Anche per ciò che concerne i disturbi alimentari c’è stato un raddoppio caratterizzato da intensificazione di richieste di trattamento in soggetti che già ne soffrivano e nuovi casi dovuti dall’isolamento che è stato imposto ed anche dalla continua alternanza tra didattica a distanza e in presenza che ha portato le ragazze anoressiche a sentirsi molto influenzate nelle dinamiche dipendenza-indipendenza, intrusività e controllo per la maggior presenza dei genitori a casa, in realtà assenti perché impegnati col lavoro in smart working. Rispetto al tema del suicidio, si è notato che parlarne ha creato un effetto di imitazione sociale, il cosiddetto effetto Werther. Se la stampa è meno attenta e pubblicizza la modalità di suicidio, questo elemento istiga velocemente al suicidio. Si ricordano i tre tentativi di suicidio, con una potenziale letalità assoluta, di ragazze che erano in contatto tra loro su WhatsApp e che in successione rapida si sono defenestrate con modalità abbastanza simili.
Per gli adulti valgono gli stessi criteri di ansia e stress per il rischio di contagio. Gli adulti patiscono, come in tutte le crisi sociali, la preoccupazione per il proprio lavoro. Soprattutto per chi guadagna meno si ha un aumento della preoccupazione e del senso di disperazione; elemento determinante per gli adulti l’aumento di suicidarietà.
Al di là delle preoccupazioni generiche legate al contagio, l’acuirsi della sofferenza psichica nella popolazione, così come l’alto grado di suiciditarietà, ha provocato alto stress e preoccupazione diffusa, portando gli operatori sanitari dell’area psichiatrica ad interrogarsi sul migliore aiuto da offrire ai pazienti. Sono tre le parole che il Dott. Rossi ha scelto di usare per descrivere la situazione: Nube purpurea, titolo di un romanzo del 1903 di Schiel, per rappresentare il tema della solitudine nel vivere ed affrontare la Pandemia; “sdraiati”, dal libro Gli sdraiati di Michele Serra, che si riferisce ai ragazzi sdraiati sul letto di casa ad occuparsi dei social e dei loro contatti via telefonino, oppure sdraiati a fare la DAD; “recupero”, pensando al fatto ci possa essere un recupero di speranza e di maggiore solidarietà e spinta nella popolazione ad attivarsi in un momento difficile. Ci sono state sette milioni e ottocento mila ricerche in meno nel corso del 2020 su tematiche legate ad autolesività e suicidio, come se ci fosse una sorta di spinta a tirare fuori le cose migliori e lasciare da parte pensieri di sconforto. Quindi recupero e solidarietà con la speranza che si attivino le risorse migliori, nonostante gli esseri umani rimangano egoisti e autocentrati.
È emersa la necessità di potenziare le strutture ambulatoriali, i centri diurni ed anche i ricoveri per garantire accessi più appropriati. Dato l’alto numero di ricoveri in età preadolescenziale e adolescenziale, è importante pensare all’attivazione di maggiori risorse per la Neuropsichiatria Infantile e servizi di psicologia, come ad esempio l’intervento sulle fragilità delle famiglie definite “a rischio”, per genitori troppo giovani oppure che hanno una fragilità psicologica. Un intervento clinico precoce in questi ambiti può essere una forma di limitazione per i disagi successivi, così come dimostrato all’estero da esperienze quali il minding the baby di Arietta Slade in America, per favorire la comprensione e mentalizzazione del genitore sul proprio figlio piccolo, e limitare lo sviluppo di psicopatologie successive; intervento messo in pratica anche in Italia qualche anno fa, ma che per mancanza di fondi era stato chiuso e che potrebbe tornare in moto se i fondi ripartissero, affinché possa essere un’attività di tutti i settori sanitari, neuropsichiatria infantile compresa.
>>> Leggi l’articolo completo qui pp. 105-110 <<<
AUTRICI:
Simona Gazzotti – PhD, psicologa, psicoterapeuta ANEB, Docente presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Istituto ANEB
Costanza Ratti – PhD, psicologa, psicoterapeuta ANEB, lavora presso Fondazione Esperia a Milano, Coordinatrice area News ANEB
Introduzione a cura di Giorgio Cavallari – Psichiatra, Psicoterapeuta, Direttore Generale ANEB, Direttore Scientifico Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Istituto ANEB e Responsabile Scientifico area editoriale.
Abstract a cura di Dr.ssa Elisa Di Pierro – Psicologa e Psicoterapeuta ANEB. Terapeuta Practitioner EMDR. Cofondatrice e Terapeuta del Centro Integrato Psiche&Corpo a Varese. Collaboratrice della rivista MATERIA PRIMA.
Immagine
Dott. Giorgio Rossi, Direttore S.C. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza









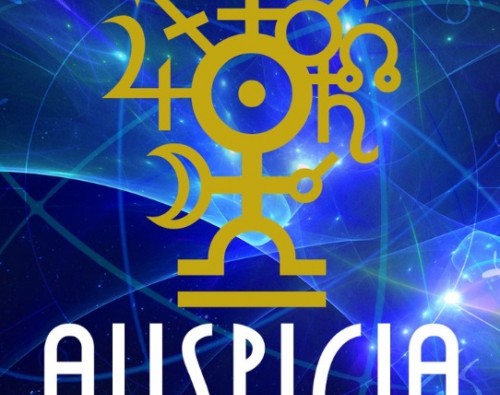
 Accedi all'area riservata
Accedi all'area riservata