Nativa Sorgente
di Costanza Ratti
Di recente mi sono capitate due piacevoli coincidenze. La prima in novembre, sull’isola di San Giulio, un piccolo lembo di terra adagiato sul lago d’Orta, dove mi ero recata per trascorrere una giornata di sole autunnale. Un po’ meno battuto dei tre grandi laghi del nord Italia, il lago d’Orta, appartato tra le Prealpi piemontesi, ha una sua particolare riservatezza, soprattutto in autunno quando il precoce declinare del sole e la sua curva bassa rendono la luce brillante e l’aria tiepida.
Sbarcata sull’isola, dopo averla circumnavigata con un motoscafo del trasporto pubblico, mi appresto a ripetere il giro da terra seguendo l’unica via pedonale, la "via del silenzio e della meditazione”. E proprio di fronte al portone di un’ampia residenza, incontro un amico che non vedevo da tempo: dopo la laurea in psicologia, aveva intrapreso un’altra strada, era diventato sacerdote e risiedeva temporanemaente sull'isola. L’incontro è stato una vera sorpresa, tanto più inaspettata poiché avveniva in un luogo così ameno. Scopro quindi che quel vasto edificio incorniciato dal verde è il monastero di Santa Maria Ecclesiae, un’istituzione che ospita più di settanta monache di clausura che vivono praticando il silenzio, la preghiera, il canto, lo studio e lavori manuali secondo la regola benedettina. Ricordando la comune passione per la poesia, il mio amico mi ha regalato un piccolo libro di Anna Maria Canopi, la fondatrice del Monastero. “Mia nativa sorgente” è il titolo della raccolta.
L’altra situazione non è propriamente una coincidenza ma una novità, che condivide con la prima il carattere imprevedibile della sorpresa. Una persona a me vicina mi consiglia con un pizzico di complicità femminile un libro dal titolo “Memorie di una maitresse americana”. Una maitresse! Dopo lo stupore iniziale, che aveva però più il profumo del nuovo che quello stantio del conosciuto, decido di comprare il libro e di leggerlo.
I due testi mi sembrano comporre un rassicurante insieme, e accostare, in questo breve articolo, due esperienze femminili così apparentemente lontane e distanti, mi pare un tentativo di operare, anche dentro di me, un’integrazione, un esperimento di ecobiopsicologia.
Per Anna Maria Canopi, originaria di Piacenza, l’amore per quel Dio a cui ella dedicò la sua vita, avvenne molto presto, dapprima, bambina, assaporando con straordinaria intensità la celebrazione del Natale del quale ricorda il bacio al Gesù bambino (“Mi rimaneva a lungo sulle labbra la dolcezza di quel bacio; era una dolcezza che mi riempiva il cuore”), e poi adolescente ritrovando quello stesso amore guardando, nell’intimo del silenzio, il cielo. “Mi piace il cielo, sempre di più mi piace il cielo (…) Io non ho nulla, quando mi guarda e lo guardo, è mio”, così scrive in una poesia dedicata al cielo (Canopi, 2015, p. 17).
Le poesie della raccolta, scritte in un linguaggio essenziale ed evocativo, come pennellate nitide su una tela bianca, testimoniano il rapporto profondo di Anna Maria Canopi con la natura e con Dio, dove l’una parla dell’altro e viceversa, e dove si colgono in controluce anche le coloriture emotive di colei che scrive. Il fiore, l’alba, il sole, la pioggia, il tramonto, il deserto, la sera, i fiumi, compongono un paesaggio naturale ma soprattutto un paesaggio dell’anima in cui ogni elemento ne racconta una qualità particolare: “fiumi placidi, fiumi travolgenti, onde di gioia, flutti di dolore” (Canopi, 2015, p. 35) trovano un loro convergenza e unità nell’essere in relazione a un Tu (la pace, l’Oceano infinto, il blu del cielo), l’amato da cui ella un giorno fu presa (come si legge nella poesia “Prima del Sole”). Si coglie così in tralice anche il racconto di una personalità che si scopre, si conosce, e si fa, nel corso di una vita, non senza quella dose di patimento che inerisce per natura al sentimento vivo.
Guardando le numerose pubblicazioni di cui ella fu autrice, che spaziano dalla poesia, alla teologia, dalla filosofia all’esegesi, si osserva anche la sua fecondità come studiosa. In un testo scritto come commento al Cantico dei Cantici, Anna Maria Canopi descrive il principio della vocazione: “Di questo bacio (del battesimo, nda) ne è rimasta in noi la fragranza, il profumo, quasi un richiamo. Crescendo noi in età questo richiamo si è fatto più vivo, più forte e ad un certo momento, che forse non sappiamo nemmeno ben precisare, nella giovinezza, nell’età dell’amore, abbiamo sentito che avevamo già incontrato l’Unico, l’Amore in persona e che non potevamo unirci a nessun altro se non a lui. Abbiamo sentito una fascinosa attrattiva – Attirami dietro a te, corriamo – che si è fatta sempre più esplicita e chiara: essa veniva da oltre i confini della terra. E per questo più nessun amore umano ci poteva bastare. Ogni gesto umano, ogni espressione umana dell’amore, ci sembrava solo un semplice abbozzo, qualcosa di incompleto mentre l’anima nostra anelava al tutto. Ecco allora sorgere impetuoso il desiderio di essere introdotti nei segreti dell’amore, il desiderio di trovare quelle espressioni della tenerezza divina che superano ogni intendimento umano: attirami dietro a te. Ma dove e come cercare? Il profumo che quel bacio ci aveva lasciato nell’anima ha indicato la direzione e noi ne abbiamo seguito la scia” (Canopi, 2014, pp. 14-15).
Il lessico è quello dell’amore, un amore tenero e appassionato. Seguendo quella scia, con cura e dedizione, Anna Maria Canopi fece dell’isolotto di San Giulio, praticamente arido e disabitato nel 1973 quando vi giunse con cinque novizie, un luogo rigoglioso e un centro di attrazione e irradiazione spirituale, fonte di ispirazione per nuove vocazioni.
In alcune interviste che ha rilasciato da anziana, si intuisce come il ritiro dal mondo, con la clausura, sia stato per lei non solo un bisogno di raccoglimento, e di protezione, ma una scelta profondamente sentita, e perseguita con tenacia e metodo, di indirizzare la sua ricerca verso una precisa direzione interiore, in una sorta di distillazione (ascesi) del silenzio, inteso non come assenza di parola, ma come “il grembo della parola” da cui ogni cosa nasce. Così la contemplazione, nelle parole della Canopi, non è concepita come muta inattività, ma come “una centrale elettrica” in cui “quella che sembra una staticità è una forza motrice”. “Mentre sembriamo immobili e chiusi – continua - percorriamo il mondo”.
In un’altra intervista, Anna Maria Canopi ci racconta di un’attrice che venne un giorno in visita al monastero e, rimasta stupita, disse: “Come è possibile che non sia Dio uno che ha tutte queste spose, come è possibile che queste donne siano qui per nessuno?”. Testimoniare, con la sincerità e l’ardore del proprio sentire, un frammento di ciò che non si vede con i sensi, fu una delle silenziose ma energiche opere di Anna Maria Canopi.
Nell Kimball, nacque in una cascina dell’Illinois nel 1854, in un ambiente come quello rurale americano di fine Ottocento che mescolava, in un amalgama scarsamente integrato, alcuni principi oppressivi ricavati da una gretta applicazione protestantesimo (senso di colpa, punizioni corporali, senso del peccato ecc.) ad una licenziosità sessuale a tratti esasperata e talvolta priva di limiti generazionali, oltre ad una scarsa istruzione e a limitatissimi stimoli culturali. Nonostante il clima oppressivo, per Nell una fiamma si accese. Essa risiedeva nel suo corpo di donna, proprio nel punto su cui ella sedeva ogni giorno senza saperlo. Come zia Letty un giorno le rivelò: “ogni donna è seduta sulla sua fortuna e non lo sa”.
Quel punto alle pendici del bacino pulsava al ritmo della natura fin da quando, poco più che bambina, in alcune sere in cui la luna era bassa all’orizzonte - Nell racconta -: “Me ne andavo giù per la strada e mi buttavo nell’erba alta e ascoltavo un cane che abbaiava in qualche lontana cascina, e il canto dei grilli acquattati nell’edera. Mi mettevo a sospirare senza nessuna ragione, e mi sentivo come se la notte e me fossimo una cosa sola, senza parole. Non avevo parole. (…) Cominciavo a far l’amore da sola, prima pian piano, poi sempre più in fretta, fino ad arrivare a un bell’orgasmo. E d’un tratto era come se fossi lontana un migliaio di miglia da quella disgraziata cascina, e da quel matto, quel bigotto, fanatico di mio padre, da mia madre ridotta a un cencio, dal letame, dal ciarpame del granaio (…). Poi sentivo il sudore raffreddarmisi sul labbro superiore e me ne restavo lì, così bene, così soddisfatta. Ero io. E se era l’estate di San Martino, col piacevole odore un po’ aspro delle stoppie bruciate, e nell’aria fluttuava la polvere dei campi mietuti, quasi venivo meno” (Kimball, 1983, pp. 54-55).
Sentire il piacere del corpo per Nell non era solo via di fuga da un mondo che non si curava affatto delle individualità, dove i figli erano trattati come forza lavoro e molto spesso morivano nei primi anni, ma era anche scoperta di una vitalità femminile che le apparteneva, bruciava (“ero talmente viva che mi sentivo fumare”, 1983, p. 66) e la metteva in contatto con una forza più grande, il cielo notturno che la circondava come una volta, mentre l’erba alta la sosteneva come un giaciglio.
Senza altre alternative che fuggire dalla sua abitazione natale e andare in città inseguendo un sogno presto infranto, Nell diventa prostituta in un bordello di lusso - sempre descritto con fedele aderenza alla realtà, senza idealizzazione e giudizio, senza nascondere brutture, pericoli e anche momenti lievi - un lavoro che a soli 15 anni le consente di mettere da parte dei soldi e di fare del suo istinto naturale, un’arte amatoria raffinata, da cui trarre quella punta di orgoglio, tipica di ogni professione ben riuscita.
Brava per Nell era colei che esercitava il suo lavoro con professionalità e giudizio, coinvolgendo il corpo ma non i sentimenti, tenendo le emozioni personali fuori dal commercio della carne. “Mi ero fatta una sorta di corazza protettiva come quella di Re Artù, sul tipo di quelle che si vedono nei musei, fatte di una camicia di ferro e calzoni di ferro. La mia era fatta di amor proprio e nell’evitare di scoprire il mio vero io. Naturalmente non sapevo affatto che cosa fosse, il mio vero io, ma lo proteggevo lo stesso” (1983, p. 141).
Scambiare un’infatuazione per amore era ciò che Nell rifuggiva. Aveva visto colleghe più ingenue affidare i propri sentimenti a uomini brutali, perché dopo tutto innamorarsi era, per una donna di casino, l’unico modo per non sentirsi solo una cosa, ma un essere umano.
Dotata di una straordinaria intelligenza naturale, Nell riuscirà ad emanciparsi dal bordello e a fare esperienze di amore romantico e drammatico. Più tardi a diventare lei stessa tenutaria di case di lusso, e ad acquisire l’istruzione necessaria per diventare scrittrice della sua vita e fornirci un contro-ritratto vivido e realistico dell’America a cavallo tra Ottocento e Novecento.
Tutto in Nell è esperienza di vita descritta con l’immediatezza lampante di una donna che fiuta la realtà attraverso i sensi e sa rielaborarla attraverso uno sguardo personale (unique, è la parola che usa per descrivere quei momenti in cui si ha piena consapevolezza di sé).
Così l’autrice descrive il momento in cui la corazza con cui si proteggeva dalle emozioni svanisce al conoscere il futuro marito: “Tutto era liquefatto, come fossi fatta di zucchero e mi stesi sciogliendo dentro una vasca da bagno” (1983, p. 216); “Fu la liquidazione completa di tutto ciò che avevo fatto nella mia vita. Mi squagliai semplicemente, come si squaglia un pezzo di lardo gettato in una pentola di zuppa bollente. Presi l’amore così come mi veniva da Monte. Allungavo le mie antenne e queste mi dicevano che ero soddisfatta e felice. Non me ne importava un fico secco se questo fosse bene o male per me. Io appartenevo a Monte. Quello era l’amore, la rovina di una buona puttana: diventare la moglie di qualcuno e amare un solo uomo” (1983, p. 218).
La rovina della sua professione era, come lei stessa sapeva, la sua nascita come donna. Amare un uomo con trasporto e dedizione, per Nell equivaleva a trasformare l’antica scoperta di un piacere naturale, in un piacere umano e sempre più individuato, che al coinvolgimento dei sensi univa la tenerezza degli affetti e la quiete di semplici momenti condivisi, mentre la coscienza di sé si espandeva di pari passo, incorporando al suo interno anche il mondo dei sentimenti e introducendo l’esperienza, seppur fugace, della sicurezza e della pace.
Raccontare, con la sincerità del proprio essere, un frammento di ciò che non si vede con la ragione, ma si prova con l’immediatezza del corpo, è uno dei meriti del libro della Kimball.
Pur nella diversità di queste due vite al femminile, mi sembra di cogliere un guizzo affine: una scintilla capace di mettere in moto un progetto e di operare nel tempo una trasformazione del femminile verso una più ampia e sottile coscienza del sé individuale (quello che rende unique) e di quello archetipico, spirituale (ciò che rende figli di… Dio, la vita) in un modo per cui la nativa sorgente del Sé e la fortuna su cui ogni donna è seduta, se concepite in maniera analogica, non paiono più come due universi distanti e inconciliabili ma come forme che originano e sono dirette a un medesimo punto, un punto che potremmo descrivere con le parole del dott. Frigoli come “il pieno” della vita. “Se l’amore è thaumàzein, cioè stupore, esso significa che si sdegna di ciò che è ancora separato e dunque “vuoto”, perché vuole conoscere la possibilità del “pieno” della vita, quello che Eraclito aveva definito “l’intima natura delle cose che ama nascondersi” (Frigoli, 2016, p. 67).
Quella natura, intuita nell’infanzia con l’immediatezza dei sensi o dello spirito, custodita come le cose preziose, è allora qualcosa di più di una singola esperienza di piacere da rievocare dolcemente nel ricordo. Attraverso la cura del sentimento vivo, può farsi sorgente di un sentire in consonanza con ciò che ci circonda.
Ciascuna di queste due donne meriterebbe un approfondimento molto più vasto che non posso proporre in questa sede. Soprattutto per Anna Maria Canopi i materiali disponibili sono molti: a partire dalle sue numerose pubblicazioni, gli articoli in suo ricordo, fino alle interviste video che sono presenti su youtube. Tra esse ne segnalo due in particolare, di breve durata, dalle quali si può cogliere qualcosa in più di quella pratica del silenzio di matrice benedettina a cui ella dedicò la sua vita.
Bibliografia
Canopi A. M. (2015), Mia nativa sorgente, Morcelliana, Brescia.
Canopi A. M. (2014), Voglio cercare l’amato del mio cuore, Edizioni San Paolo, Milano.
Frigoli D. (2016), “L’amore: il paradiso perduto”, in Materia Prima, Vol. XV, pp. 65-71.
Kimball N. (1983), Memorie di una maîtresse americana, Adelphi, Milano.
Interviste
Antonino d’oro 2015 – Intervista a Madre Anna Maria Canopi:
https://www.youtube.com/watch?v=tkSI2ocA8R4&t=25s
La voce del silenzio, puntata 31 gennaio 2018:
https://www.youtube.com/watch?v=YHFCBaZzzTI&t=44s





_(2).jpg)



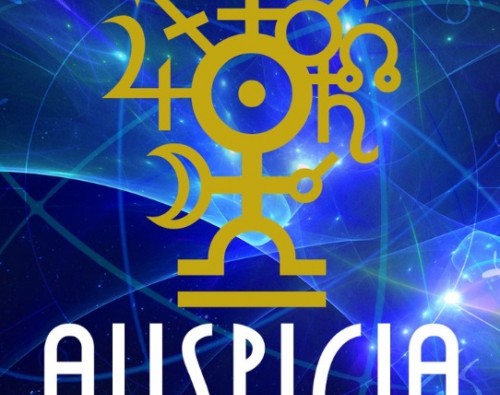
 Accedi all'area riservata
Accedi all'area riservata