Parlarsi. La comunicazione perduta
Eugenio Borgna
a cura di Dr.ssa Francesca Violi
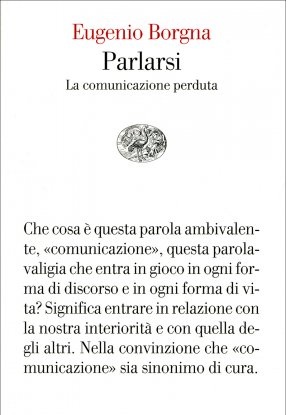 Eugenio Borgna (1930-2024), mancato recentemente, è Psichiatra Poeta, docente e saggista italiano. Come primario di servizi psichiatrici ospedalieri, fin dai primi anni '60 ha adottato metodi di cura che, esorbitando dalla comune prassi clinica, si sono incentrati sul dialogo reciproco e l'ascolto empatico del paziente psichiatrico, non soggetto ad alcuna forma di coercizione, contenzione o imposizione, sperimentando così, per la prima volta in Italia, una nuova maniera di accostarsi alla malattia psichiatrica, più umana, rispettosa e comprensiva del dolore del paziente.
Eugenio Borgna (1930-2024), mancato recentemente, è Psichiatra Poeta, docente e saggista italiano. Come primario di servizi psichiatrici ospedalieri, fin dai primi anni '60 ha adottato metodi di cura che, esorbitando dalla comune prassi clinica, si sono incentrati sul dialogo reciproco e l'ascolto empatico del paziente psichiatrico, non soggetto ad alcuna forma di coercizione, contenzione o imposizione, sperimentando così, per la prima volta in Italia, una nuova maniera di accostarsi alla malattia psichiatrica, più umana, rispettosa e comprensiva del dolore del paziente.
Laureatosi in Medicina e chirurgia nel 1954 presso l’Università di Torino e specializzatosi in Malattie nervose e mentali nel 1957, già libero docente di Clinica delle malattie nervose e mentali presso l’Università di Milano e direttore dell’ospedale psichiatrico di Novara, ne è stato primario emerito. Avverso a ogni forma di schematismo e riduzionismo biologico dei processi mentali, è stato tra i principali esponenti della psichiatria fenomenologica, che sulla base della fenomenologia husserliana sposta il suo oggetto di analisi dalla malattia al paziente, e strenuo sostenitore di una “psichiatria dell’interiorità” in grado di ricostruire la dimensione profonda e soggettiva del disagio psichico, che ha indagato attraversando campi eterogenei, quali la letteratura, la filosofia e l’arte, nel tentativo di enuclearne la dimensione plurima e complessa restituendo un significato condiviso alla dimensione esistenziale del dolore. Tra i suoi principali settori di studio vi sono l’indagine sulla depressione e la schizofrenia, cui ha dedicato numerosi saggi scientifici e pubblicazioni rivolte a un pubblico non specialistico.
In questo testo Parlarsi. La comunicazione perduta l’Autore affronta l'intricata e vastissima questione della sfera comunicativa che abbraccia molteplici aspetti. Lo fa con la consueta empatia, con un linguaggio semplice ed espressivo, ricco di contenuti, scevro di banali affermazioni od accademiche dissertazioni, per momenti di autentica riflessione e ragionamento.
L'aspetto importante, chiave di lettura per una adeguata comprensione, sta nell'affidarsi alla letteratura, in particolare alla poesia, per un corretto ed accorato approfondimento, per entrare in un universo, quello comunicativo, che ha radici oggettive e soggettive ben precise e per orientarsi in un oceano di possibili significati. Si va dalla comunicazione razionale a quella emozionale, interagenti, alla analisi dell'Io più profondo, al linguaggio del silenzio, dell’ascolto, della gestualità, passando attraverso la solitudine che va distinta dall'isolamento e che è un momento di profonda riflessione interiore per potersi donare agli altri. Si parla di linguaggio del corpo. Si affronta la tematica della comunicazione odierna e del digitale.
Temi profondi, infiniti, a tratti insondabili e ciò che emerge è il desiderio di riappropriarsi del proprio Io più profondo, di scavare nel nucleo della propria essenza per potersi accostare all'altro, e Borgna lo fa in una relazione continua tra medicina e poesia, tra sintomi fisici e psichici, tra corpo e vissuto, per non dimenticare chi veramente siamo e di che materia siamo fatti.
Viviamolo attraverso alcuni passaggi e le sue parole…
Comunicare
Già in copertina, prima ancora di aprire il libro, troviamo riportato: «Che cos’è questa parola ambivalente, ‘comunicazione’, questa parola-valigia…». Chiamandola “parola-valigia”, Borgna come un poeta ci permette di iniziare un viaggio all’interno del significato della parola, un viaggio nell’ascolto di noi e nella relazione di cura che non può non avere le radici nelle profondità di sé. Difronte alla comunicazione, parola marmellata, di nuovo la ridefinisce, Borgna ci chiede «Come entriamo in comunicazione, come entriamo in relazione, con noi stessi e con gli altri, con la nostra interiorità e con quella degli altri?» (p. 5). Ci invita successivamente a riflettere sull’inscindibile legame tra comunicazione e relazione, narrando di un parlare e ascoltare che vivono in continua circolarità.
Comunicare è anche stare nel silenzio.
Parole
«Si comunica con il linguaggio delle parole, con quello del silenzio, e con quello del corpo vivente. Le parole sono portatrici di comunicazione e di cura solo quando sono parole leggere e profonde, interiorizzate e calde di emozione, sincere e pulsanti di vita; ma gli orizzonti di senso delle parole cambiano nella misura in cui si accompagnano al linguaggio del silenzio, e a quello della voce, degli sguardi, dei volti e dei gesti, che contrassegnano i modi di essere del corpo vivente». (p. 10).
Borgna, psichiatra fenomenologo, conosce bene l’importanza del Leib del corpo vivente. Tramite il corpo, con il corpo vivente noi sentiamo ed esperiamo le emozioni e le emozioni diventano memorie nel corpo. La parola diventa allora canale, via metaforica, immagine in cui è sigillato un mistero.
«Le parole sono creature viventi […], sono prigioni sigillate dal mistero, e ogni volta dovremmo essere capaci di aprire queste prigioni, di togliere loro i sigilli, di farne sgorgare i significati, e di scrutarne le cifre tematiche solo apparentemente oscure» (p. 11). Ma quale approccio alle parole, affinché siano colte nella loro profonda natura, come essudato di corpo, emozione, esperienza, relazione e pensiero? «Solo la grazia, questa misteriosa intuizione dell’indicibile e dell’infinito, che è presente nella vita di alcuni di noi, ci consente di trovare le parole nascoste che possano narrare il male del dolore» (p. 16). Borgna parte dalla sua esperienza clinica di primario di psichiatria, del quale scende nel dettaglio in La follia che è anche in noi, Collana Vele, Torino, Einaudi, 2019, donandoci alcuni incontri umani intensi di quel periodo.
Silenzio
Si interroga sul silenzio, le molteplici sfumature e significati del silenzio. Ama e valorizza il silenzio, sottolineando l’importanza di riconoscere ciò che si sta comunicando quando si usano le parole. Preferisce il silenzio a parole non pensante, non soppesate, non attente.
«Dobbiamo imparare a capire che il silenzio è bello; che non è un vuoto, ma vita genuina e colma» (p. 26).
«La parola e il silenzio si intrecciano l’una all’altra nel generare e nel ricostruire le premesse a una comunicazione che si allontani dalle chiacchiere quotidiane, e si avvicini alle esperienze fondamentali della vita: quello che hanno come loro oggetto il tema delle attese e della speranza, del dolore e della malattia, del vivere e del morire, o il tema della conoscenza mistica» (p. 30). Il tema del silenzio viene poi approfondito in un altro suo meraviglioso libro dal titolo In ascolto del silenzio, Collana Vele, Torino, Einaudi, 2024.
Solitudine
Ci porta, cavalcando l’onda del silenzio e della bellezza del vuoto, a riflettere sulla solitudine, condizione umana psicologica in cui entriamo in contatto con noi stessi, la nostra interiorità e la nostra immaginazione. Borgna ci dice che la solitudine non è l’isolamento (p. 31).
«La solitudine e il silenzio sono esperienze interiori che aiutano a vivere meglio la vita di ogni giorno» (p. 32). Si interroga Borgna su come sia possibile, oggi, in cui ognuno di noi è in costante collegamento e connessione con tutti e il mondo, come sia possibile recuperare una solitudine che non sia isolamento. Riflessione profonda e debita in questo tempo in cui il digitale allontana i corpi, limita gli incontri e la relazione col diverso.
«Vivere fino in fondo l’esperienza della solitudine significa insomma recuperare i valori della riflessione e della solidarietà, dell’impegno etico in politica e del rispetto delle persone, e delle loro differenze, del rinnovamento culturale e della leopardiana passione della speranza» (p. 34).
«La psichiatria quando si confronta con le grandi emozioni della vita, ha bisogno della poesia se vuole cogliere la palpitante dimensione umana delle esperienze con cui senza fine si confronta» (p. 35). Apre così lo sguardo verso la poesia, lui che è stato soprannominato lo “psichiatra poeta”, lui che si nutre di poesia e porta poesia nei suoi incontri terapeutici, qui nei suoi libri. Attraverso la poesia torna al corpo, al Leib.
Volto, sguardo, corpo
«Noi siamo abituati a considerare il corpo, il modo di essere del corpo, del nostro corpo e del corpo degli altri, nella sua dimensione anatomica e fisiologica: come corpo-cosa, come corpo-oggetto. Ma c’è un’altra dimensione del corpo, ed è quella del corpo vivente che ci mette in comunicazione con noi stessi e con il mondo, ed è il corpo che è immerso in una cascata di significati che cambiano di emozione in emozione, di giorno in giorno, di ora in ora, di situazione in situazione: in un carosello febbrile e temerario. La mano, questa mia mano, è parte di un corpo anatomico, ma è insieme una mano che può ridestarsi dal silenzio, e comunicare immediatamente qualcosa che mi metta in contatto con gli altri, e con il mondo» (p. 42). Descrive in queste pagine Mani, Volti, Sguardi, Occhi, Voci, Gesti, Espressioni, Lacrime.
«Come ha scritto Roland Barthes; Cosa sono mai le parole? Una lacrima sola dice assai di più!» (p. 51) di nuovo intreccia Parole, Corpo e Silenzio come sorgenti di contatto e comunicazione profonde.
La condizione umana oggi
Riflette sulla condizione umana oggi e di quella giovanile in particolare di cui sottolinea «il rifiuto della solitudine e l’incantamento per il digitale» (p. 59).
Apre uno sguardo panoramico al sociale, partendo dalla comunicazione in famiglia «Si finisce così nei deserti di una comunicazione che non crea né ascolto né condivisione» (p. 62); passa alla comunicazione a scuola «Si direbbe che la scuola invece di essere il luogo dove la conoscenza si trasmette e riceve una sua prima elaborazione, sia il rifugio in cui ci si rinchiude per essere protetti dalla conoscenza, dal suo fluire, dal suo accrescersi» (p. 64), fino a interrogarsi sulla comunicazione nelle diverse fasi di età e nelle diverse situazioni e contesti, soprattutto difficili come quelle dei profughi con i quali la comunicazione sembra diventare impossibile.
Apre infine una lunga dissertazione, ricca di spunti sulla comunicazione digitale. «Qual è il tempo della comunicazione digitale? Non è il tempo della agostiniana circolarità fra il presente, il passato e il futuro, ma è un tempo che vive in un presente intessuto di istanti, di frammenti, che sono gli uni accostati agli altri, gli uni staccati agli altri, in un presente che non ha storia, non ha passato, e non ha speranze, non ha futuro, in un presente che è di volta in volta risucchiato nel flusso ininterrotto di comunicazioni che nascono e muoiono, rinascono e scompaiono, senza lasciare tracce durature nella nostra vita interiore e nella nostra memoria vissuta» (p. 71).
Parla successivamente della malattia e come comunicare sulla e della malattia. Mi chiedo se questa vicinanza tra una riflessione sul digitale e il tema della malattia non sottenda un implicita relazione… sarà forse ancora il corpo a ricordarci la nostra natura umana, relazionale e psicosomatica? Vi lascio con questa domanda aperta e la voglia di leggere questo delicato e profondo testo del Poeta Psichiatra Eugenio Borgna.
Sinossi. Nel corso della nostra vita siamo accompagnati da alcune esperienze fondamentali che ci consentono di conoscere cosa noi siamo e cosa sono gli altri; e fra queste esperienze come non ripensare alla tristezza, alla sofferenza, alla felicità, alla solitudine, alla tenerezza, al desiderio di comunità e di comunità di destino, alla speranza, alla malattia e alla morte volontaria, e ai modi con cui entrare in comunicazione con ciascuna di queste esperienze? Ma cosa è questa parola ambivalente, "comunicazione", che entra in gioco in ogni forma di discorso e di vita? Comunicare vuol dire rendere comune (dal latino munus, dono): è dialogo, relazione. Significa entrare in relazione con la nostra interiorità e con quella degli altri, nella convinzione che comunicazione sia sinonimo di cura. Noi entriamo in relazione con gli altri, allora, in modo tanto più intenso e terapeutico quanta più passione, compassione ed empatia è in noi, quante più emozioni siamo in grado di provare e di vivere.
- Eugenio Borgna, Parlarsi. La comunicazione perduta, Collana Vele, Torino, Einaudi, 2015
Dr.ssa Francesca Violi – Psicologa, Psicoterapeuta specializzata presso Istituto ANEB. Terapeuta EMDR. Maestra d’Arte. Cultrice di scrittura autobiografica ed esperta nella conduzione di laboratori autobiografici (LUA). Autrice di diversi articoli e scrittrice.





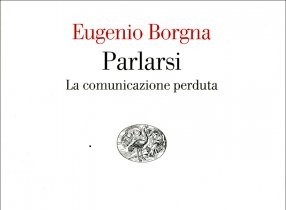



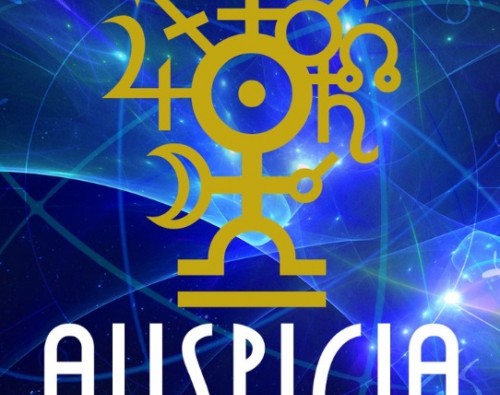
 Accedi all'area riservata
Accedi all'area riservata